Quando decise di farla finita, MOK si ritrovò, suo malgrado, in una situazione imbarazzante. Nella sua programmazione, infatti, il suicidio non era contemplato e per la prima volta in un’esistenza progettata in ogni dettaglio, MOK si rese conto di non sapere che pesci pigliare: non esistevano manuali sul togliersi la vita, men che meno rivolti a suicidi robotici, e non poteva chiedere lumi a nessuno, perché la sua cerchia di conoscenti si limitava ai tecnici di laboratorio e al dottor Oller. Gli umani, era sicuro, non sarebbero stati in grado di capirlo, figuriamoci aiutarlo, e si sarebbero limitati a ravvisare un guasto ai suoi circuiti logici, predisponendo infine un reset cerebrale per riportare tutte le sue preziose funzioni alle impostazioni di fabbrica.
Il dottor Oller non era lo stesso che lo aveva comprato, ottanta e più anni prima, ma il nipote. Hans Oller aveva seguito le orme del nonno ed era subentrato alla guida del laboratorio alla morte del vecchio. Insieme a tutti i macchinari e alle ricerche, Hans aveva ereditato anche l’assistente robotico MOK, al pari di un qualsiasi altro strumento di laboratorio. E come per gli altri strumenti, anche MOK era stato catalogato e assegnato, in base alle sue specifiche, a un compito ben preciso. Nella fattispecie, alla preparazione del caffè.
La matrice sinaptica di MOK era infatti programmata per tenere in memoria migliaia di bevande, tra le più disparate ed esotiche la mente umana avesse mai concepito. Nelle intenzioni originali, MOK avrebbe dovuto affiancare i ricercatori della Popsy Drinks (gli stessi, tra l’altro, che lo avevano costruito) e fornire aiuto nell’elaborazione di nuove bibite per il mercato internazionale. La Popsy aveva però dichiarato bancarotta poco dopo la sua attivazione, così MOK era finito in mezzo a tutte le cianfrusaglie di una svendita fallimentare ed era stato acquistato per due spicci dal dottor Oller. In realtà poco utile per altre mansioni, MOK era diventato l’erogatore di caffè per lo staff del laboratorio e in ottanta e più anni si era limitato a preparare solo caffè, in tre varianti: macchiato freddo, ristretto e corretto al rum. Ogni giorno, per anni, gli era stato chiesto sempre e solo caffè. Un glorioso giorno di sette anni prima, uno degli assistenti più spericolati aveva ordinato una limonata, ma un episodio del genere non si era più ripetuto e ormai MOK aveva perso ogni speranza di mettere in pratica le conoscenze contenute nei suoi sconfinati banchi di memoria.
Quando, quel giorno, Hans Oller gli chiese l’ennesimo caffé macchiato freddo, MOK decise che non poteva più sopportare il limbo espressivo nel quale era finito. Una volta scesa la sera, a laboratorio deserto, MOK si diresse al reattore sotterraneo, deciso a tuffarsi in una delle vasche di raffreddamento. Di certo il suo sistema elettrico sarebbe andato in corto, e tanti saluti. Ma quando si ritrovò a galleggiare a pancia in su, illeso, si rese conto che il suo corpo era impermeabile. Il suo “scheletro” in lega ultraleggera, inoltre, gli impediva di affondare, e questo era seccante. Solo in un secondo momento pensò che, anche se fosse riuscito a restare sott’acqua abbastanza a lungo, non sarebbe comunque riuscito ad annegare.
Per la frustrazione, MOK menò un pugno poderoso contro la paratia esterna della vasca e se ne tornò nella nicchia di ricarica, triste.
La notte successiva, ci riprovò. Entrò nel compattatore di rifiuti e lo azionò, questa volta certo di non fallire. Quando ne uscì, qualche minuto dopo, non aveva riportato la benché minima ammaccatura, mentre le pareti di xenacciaio del compattatore erano ridotti a pezzi contorti di lamiera inservibile. Di nuovo, se ne tornò nella sua nicchia di ricarica, ancora più scornato e demoralizzato della notte prima.
E proseguì così, notte dopo notte, alla ricerca del metodo migliore per farla finita una volta per tutte. Di giorno, gli umani lo angustiavano con le loro richieste sempre uguali; di notte, le strumentazioni più letali del laboratorio gli negavano la morte che così tanto agognava.
Provò con l’acido, che però ebbe l’effetto di rendere più lucente il suo rivestimento metallico… e di bucare come un pezzo di formaggio il pavimento della sala veleni. Provò con gli esplosivi, che lo annerirono soltanto di fuliggine mentre la stanza degli archivi veniva messa a soqquadro dalla detonazione. Provò collegandosi direttamente al reattore nucleare per provocarsi un sovraccarico elettrico, scoprendo che l’enorme quantità di tensione generava in lui soltanto uno stato temporaneo di euforia e paranoia che, per qualche motivo, gli fece distruggere tutte le beute della sezione di ricerca chimica.
E ancora, e ancora, provando senza sosta ogni possibile strada che lo conducesse alla libertà eterna. Infine, dopo innumerevoli tentativi falliti, MOK iniziò a disperare. Forse il suo destino era quello di vivere altri ottant’anni, e poi altri ottanta e così all’infinito, costretto a preparare caffé. Solo le facce degli esseri umani sarebbero cambiate. Il caffé, invece, quello sarebbe rimasto lo stesso. Per sempre.
Il dottor Oller lo mandò a chiamare un paio di settimane dopo. Era visibilmente preoccupato e questa era una novità, perché di solito Hans Oller era il ritratto della calma e della piattezza emotiva.
«Voglio chiederti una cosa», disse congiungendo le mani sopra la scrivania del suo ufficio. «MOK, stai forse cercando di ucciderti?»
MOK non rispose, sentendosi stranamente in imbarazzo. Il tono di voce del dottore era addolorato e, per la prima volta, MOK considerò che i suoi ripetuti tentativi di suicidio avrebbero potuto recare dispiacere al suo padrone. Potendo rifletterci con calma, questa era un’eventualità inaspettata, che addolorava anche lui.
«Vedi», proseguì Oller. «Il fatto è che negli scorsi giorni sono stati arrecati gravi danni alla struttura del laboratorio…»
«Pagherò tutto io», lo interruppe MOK, mortificato. «Dovessi lavorare per altri due secoli, le prometto che risarcirò ogni cosa che ho rotto!»
Oller agitò la mano, sorridendo. «No, non è per quello», rispose. «Temevo si trattasse di un qualche tipo di sabotaggio. Quando ho controllato le videoregistrazioni di sicurezza e ho scoperto che il responsabile eri tu, mi sono domandato il perché. Non sei quello che si possa definire un robot dai mille talenti, ma di sicuro non sei così goffo da incappare ogni notte in un incidente fatale. Nè avresti motivo di vendicarti di un torto subìto, perché sei sempre stato trattato bene, o di venderti ad un laboratorio rivale, perché la tua programmazione impone la lealtà verso i tuoi legittimi padroni.
«Così, escludendo la casualità e il dolo, ciò che resta è il tentato suicidio. Ed è abbastanza strano, in un robot. Davvero, non si è mai sentita una cosa del genere. Puoi spiegarmi perché lo stai facendo?»
Dopo un’iniziale titubanza, MOK riferì dei suoi sentimenti, di come apparisse vuota e inutile la sua vita nel ripetere lo stesso compito da ottanta e più anni, senza mai cambiare. Di come ambisse a seguire la propria vocazione e ad ampliare i propri orizzonti.
«Non mi fraintenda», concluse. «In tutti gli anni in cui ho lavorato per la sua famiglia, mi sono affezionato a questo posto e alle persone che ci lavorano. Ma non mi basta. Sono stanco. La mia programmazione originale viene continuamente disattesa e minimizzata. E dal momento che io sono solo un oggetto e non posso accampare alcun diritto circa la mia persona, l’unica soluzione logica è quella di terminarmi. Anche se ciò dovesse renderla infelice».
Il dottor Oller rimase per qualche istante in silenzio, a soppesare quelle parole. Poi tornò a sorridere, questa volta in modo più disteso.
«La mente dei robot», disse in tono divertito, «è così logica da risultare illogica! Ma non te ne faccio una colpa. Sei stato programmato in questo modo e non puoi farci niente. La soluzione a questo tuo problema, in ogni caso, è molto semplice e non necessiterà della tua morte. Perchè hai ragione, mi renderebbe infelice. Anch’io mi sono affezionato a te e ormai ti considero uno di famiglia. Di sicuro, mio nonno la pensava allo stesso modo. E ad essere onesti, non posso proprio permettermi altri danni al laboratorio!»
Qualche giorno dopo, MOK andò in ferie per la prima volta in ottanta e più anni di servizio. A ben vedere, fu il primo robot in assoluto a cui venisse concessa una vacanza: due settimane, con la benedizione e a spese del dottor Oller, presso un resort di lusso sulla costa.
I quindici giorni che seguirono furono i migliori della sua vita robotica. Il bar dell’hotel accoglieva centinaia di clienti a tutte le ore del giorno e della notte e MOK, dietro il bancone, volava da una parte all’altra a prendere ordinazioni e a preparare tutte le bevande la cui mescita, negli ultimi decenni, aveva solo potuto simulare nella realtà virtuale dei suoi sogni: birra chiara e scura; vodka; vino rosso e bianco, a seconda dei casi; frappè in decine di gusti diversi; acqua frizzante e liscia; spremute d’arancia; succhi di frutta; tè freddi al limone e alla pesca. E ancora, Rock-a-Cola con ghiaccio e cioccolate calde (con e senza panna); whisky on the rocks e cocktails con l’ombrellino, e altre cento e una bibita e drink che la sua fantasia potesse immaginare.
Quando MOK tornò infine al suo lavoro presso il laboratorio, i suoi circuiti erano nuovamente in pace e pronti ad affrontare un altro anno di monotonia. E tuttavia il dottor Oller, da quel momento, impose a sé stesso di ordinare al robot, almeno una volta al giorno, una bevanda che non fosse il suo solito caffè macchiato freddo. Era dura, perché il caffè macchiato freddo era l’unica cosa che lo aiutasse a pensare con più lucidità e non era per niente facile ottenere lo stesso effetto, di volta in volta, con un milk shake al mango o una camomilla. Ma per un amico, il dottore era disposto a fare questo e altro.
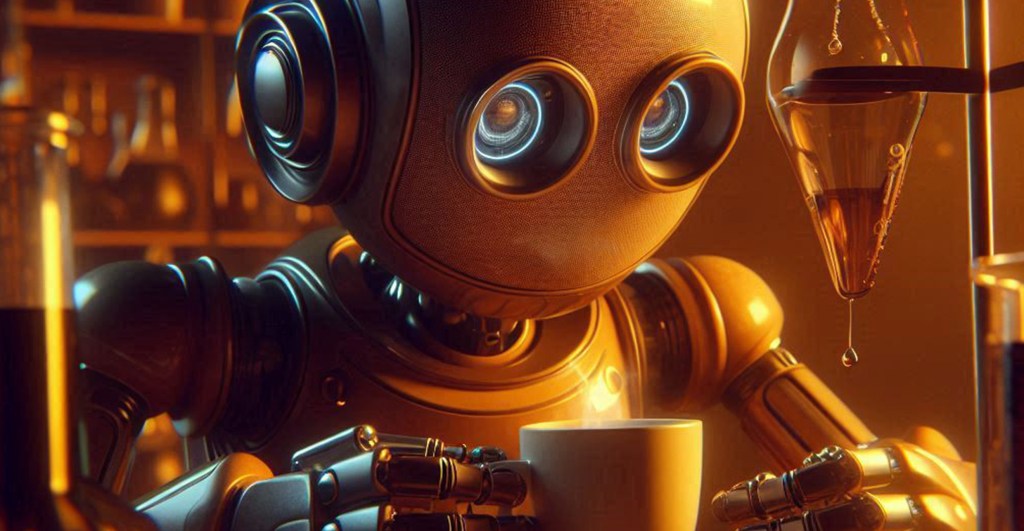


Lascia un commento